Storia breve di un mito dimenticato
È il 1995, e Cartoon Network è ormai in TV già da qualche anno. Il canale nato dagli sforzi del magnante dell’animazione Ted Turner non ha tuttavia quella verve che può permettergli di competere con realtà consolidate come quella offerta dai canali Disney. Certo, può contare sullo straordinario set di personaggi della Hanna & Barbera, ma la messa in onda di vecchi cartoon o la riproposizione di personaggi come Tom & Jerry non pare sufficiente ad attecchire sul giovane e affamato pubblico televisivo. Cartoon Network ha però dalla sua un pregio fondamentale: non è il primo canale dedicato ai cartoni animati, questo è certo, ma è il primo che offre una programmazione a base di cartoon 24 ore al giorno. Senza stop in America, con qualche compromesso notturno in altri paesi.
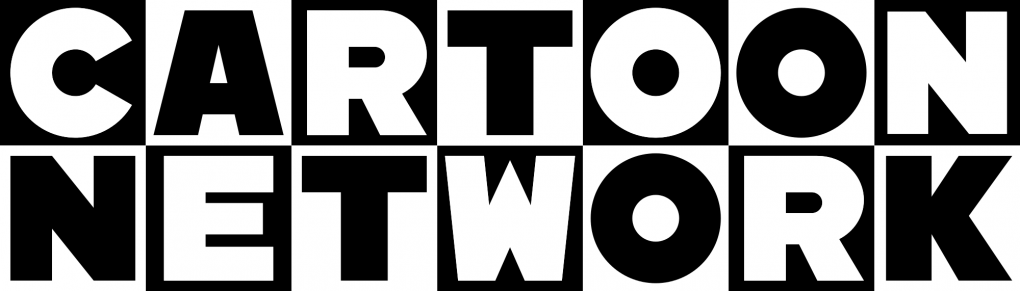
Prima di Jack
Con alla guida la granitica e illuminata Betty Cohen, e grazie ad un’idea di Fred Seibert (“solo” l’ultimo presidente di Hanna & Barbera prima che essa fosse assorbita), il canale comincia il suo viaggio verso lo sperimentalismo, proponendo al suo pubblico un piccolo blocco chiamato “What a Cartoon” o, in alcuni paesi “Toon Cartoon”. Lo scopo è semplice: produrre dei piccoli corti con nuove tecniche di animazione e sceneggiatura con l’intento di sondare il gradimento del pubblico, e trovare in quello stesso gradimento i beniamini di domani. Per quanto produrre un cartoon sia ovviamente dispendioso, Seibert e la Cohen decidono di investire sui corti perché, mal che fosse andata, la perdita economica sarebbe stata di molto contenuta. Si lanciano allora vari e nuovi personaggi, tutti protagonisti di episodi di pochissimi minuti, e tra questi, nel 1996, primeggia senza ombra di dubbio il concept di un giovane talento, che da poco aveva terminato i suoi studi presso il California Institute of Arts: Gennadij Borisovič Tartakovskij, detto Dženndm, per gli amici Genndy Tartakovsky. Dopo aver disegnato distrattamente una longilinea ballerina, ed averle contrapposto un burbero e geniale nanetto ispiratogli da suo fratello Alex, Tartakovsky, che già si era fatto le ossa lavorando negli studios di Hanna & Barbera come animatore, trova la sua occasione per il suo primo show, e sebbene esso sia solo un segmento in un progetto più grande, ha l’OK di Seibert e degli Studio per introdurre nel What a Cartoon i suoi personaggi: Dexter e Dee Dee.
Moltissimi sono i personaggi che vengono introdotti dai vari corti. Cartoon Network ebbe il pregio e l’intuizione di selezionare una rosa di giovani e talentuosi artisti, tanto che da quei corti scaturirono i più popolari beniamini di metà anni ’90. Leone il cane fifone, Johnny Bravo, Mucca & Pollo e Le Superchicche, giusto per citarne alcuni, furono tutti personaggi che, partendo dal blocco ideato da Seibert, finirono per avere un proprio show tra il ’96 e il ’99. Tra questi però ce ne fu uno che ottenne una presa esagerata sul pubblico, e questo fu proprio “Il Laboratorio di Dexter”, ossia il piccolo segmento ideato da Genndy Tartakovsky. Nel 1996 va così in onda Dexter, slegato da ogni altro personaggio, lo show diventa autonomo e ha un successo planetario, dapprima in America, poi nel resto del mondo, diventa il simbolo di un nuovo tipo di animazione, capace di coniugare intelligenza e sagacia a nuove sintesi del disegno e del movimento. Tartakovsky ottiene lodi e successo, tanto che il suo show finirà per chiudere molti anni dopo con un totale di ben 221 episodi, trasmessi dal ’96 al 2003, anche se non senza diverse interruzioni. Il Laboratorio di Dexter è una piccola e nuova consacrazione per l’animazione americana. Le puntate sono spigliate, le trame mai banali, e la rodata macchina di ogni episodio finisce inevitabilmente per richiamare a sé numerosissimi talenti, tanto che molti “aficionados” del cartone animato, come Craig McCracken, Teddy Newton e Seth MacFarlane, prestano la loro penna alla sceneggiatura di una manciata di episodi. La naturale continuità di un lavoro certosino, con pochi bassi e moltissimi alti, porta il cartoon a consacrarsi nel cuore di tantissimi telespettatori.

Quello che colpisce è lo stile apparentemente asciutto delle animazioni. I disegni sono spigolosi, apparentemente retrò. Si tratta di una sintesi nuova, che coniuga le ispirazioni delle Merry Melodies degli anni ’30 e ’40 con le nuove tecniche del movimento. Tartakovsky, del resto, è un appassionato di animazione a tutto tondo. Guarda con ammirazione al lavoro svolto dal Giappone con il popolare filone mecha, ed è affascinato dall’azione di stampo cinematografico. Il suo Dexter è dunque solo apparentemente sintetico, il movimento è leggero, i personaggi compiono mosse che sembrano tipiche dello slapstick anni ’90. I loro corpi sono disegnati guardando alle icone, e lo stesso character design punta a creare contrasti forti e memorabili. Genndy mantiene forte il richiamo al lavoro del passato di Hanna & Barbera, ma quando Dexter sfodera le sue invenzioni lo show si trasforma, si concentra su azioni che la vecchia animazione non avrebbe mai immaginato, e fa pieno uso dei suoi campi larghissimi, che lasciano non poco spazio ai personaggi su schermo. Tartakovsky trova un modello nuovo, una sintesi perfetta tra il passato dell’animazione e il presente cinematografico e Cartoon Network gradisce, tanto che imporrà lo stesso modello ad un altro grande (e popolare) prodotto d’azione, cui Tartakovsky pure darà il suo contributo: le Superchicche. Ma qui siamo solo all’inizio.
Jack
Complice il successo di Dexter, Genndy Tartakovkij ha finalmente la sua occasione di realizzare il suo sogno nel cassetto: uno show di pura azione, che si rifaccia propriamente al cinema e che riesca a coniugare soluzioni estrapolate persino dal mondo del fumetto. Il nostro è alla ricerca di un nuovo tipo di estetica dell’animazione, in cui possano confluire azione, simbolismo e una certa cura nella ricerca artistica. Il protagonista, neanche a dirlo, sarà un samurai. Una figura che ha sempre affascinato Tratakovsky e che si rifà alla sua passione per il cinema e il mondo giapponese, nonché all’ispirazione che da questo ebbe guardando il mastodontico capolavoro di Kurosawa: I Sette Samurai. Insieme al produttore dello show, Mike Lazzo, si cominciano a delineare le basi di quello che poi sarà noto a tutti come “Samurai Jack”. Una serie contenente combattimenti, arti marziali, momenti assolutamente leggeri e che fosse disegnata ed animata per competere con un prodotto di stampo cinematografico. Rifacendosi apertamente al “Ronin” di Frank Miller, Tartakovsky immagina allora la storia di un samurai senza nome, chiamato dai suoi interlocutori semplicemente “Jack” che, armato di una katana magica con il potere di sigillare il male, vive un’eterna battaglia contro un demone maligno, Aku, finendo sfortunatamente catapultato nel futuro insieme ad esso. Come per il Ronin di Miller, Jack è un outsider in tutti i sensi, fuori ogni tempo massimo. Su ispirazione del mai troppo amato “Kung Fu”, con David Carradine, il personaggio è un girovago, un vagabondo, che compie un viaggio erratico alla ricerca della sua vendetta, annessa al bisogno di tornare nel suo tempo.
A causa del suo fallimento nel passato, dovuto al paradosso causato dal suo stesso viaggio, il mondo del futuro è dominato da Aku, riprendendo ancora una volta da quel filone distopico che anche Miller aveva utilizzato per la New York del suo racconto. Tartakovsky però punta più in alto, del resto deve costruire una moltitudine di storie per i suoi episodi, e immagina che sotto lo scacco di Aku ci sia non una sola città, ma un intero mondo, dominato da una malvagità sempre sottesa ed infida. Jack, in giro per il pianeta, si troverà così a incontrare e scontrarsi con creature, popolazioni e tradizioni del tutto in antitesi con il suo retaggio, ma anche con nemici e filosofie che sembrano invece ripescate direttamente dal tempo da cui è stato esiliato. Silenziosamente, dolorosamente, non nascondendo l’insofferenza del personaggio per la lunghezza del suo viaggio e per la constatazione del suo fallimento, che ha portato Aku ad essere temuto e venerato.

Qui sta una delle prime rivoluzioni di Samurai Jack, quella del volersi distinguere dal resto delle opere prodotte in quegli anni da Cartoon Network (e non solo) per il tono sommessamente dark e malinconico delle sue avventure. L’animazione per adulti, di fatto, esisteva da tempo e aveva trovato in prodotti passati come Aeon Flux un crogiolo di tematiche crude e disturbanti. Samurai Jack non era il primo prodotto volutamente “duro”, ma era il primo prodotto dark proposto ad un pubblico di giovanissimi, su quello che era un canale che poteva avere la sua fascia media di spettatori in un’età compresa tra l’infanzia e la pubertà. Qui sta la prima vera rivoluzione.
Ma non solo: il mondo del futuro è vasto, variegato. Tartakovsky si diverte di episodio in episodio a rifarsi ai più celebri paradigmi del cinema di genere. Tutto ciò che era stato cartoon fino a quel momento viene messo da parte. Non mancano, come detto, interazioni puramente ironiche, ma Genndy guarda altrove. Guarda al western, al cyberpunk, al noir, al chambara ed al wuxia. Ogni episodio di Samurai Jack è confezionato per avere una direzione artistica da capogiro. Il mondo che il team di animazione costruisce è fuori da ogni metrica, non ha confini, non si può definire entro alcuna certezza. Esso esiste, ma di fatto è come se non esistesse. Un dogma che si ripercuote apertamente sullo stile di disegno, che talvolta si pregia di rappresentare una paesaggistica dettagliata e preponderante, altre volte mira ad una sintesi stilistica così estrema da privarsi volutamente di sfondi e linee di contorno. La stessa timeline delle stagioni viaggia con ritmi apparentemente illogici, dando agli spettatori pochissimi indizi per costruire una continuità. Ci sono solo Jack e Aku, in quello che è un circolo di vendetta e redenzione che sembra volutamente ispirarsi alle grandi opere di genere del cinema orientale. Pensate alle tematiche basilari della Trilogia della Vendetta di Park Chan-Wook. In Samurai Jack quei temi ci sono già. Ovviamente con le giuste ricalibrature, ad uso e consumo di un pubblico di giovanissimi, ma il fascino di Jack è proprio quello di vederci lungo, di puntare nella giusta direzione narrativa e di ispirarsi nel modo corretto a prodotti di straordinaria caratura.

La serie viene dunque annunciata nel 2001. Diventa brevemente un punto di riferimento per la critica e per il pubblico, con soluzioni che per un cartone animato erano sembrate, fino a quel momento, inimmaginabili. Un esempio su tutti è il modo in cui Tartakovsky si rifà alla cultura nipponica. Non solo per l’ovvia tematica del samurai. Ripescando da cinema e teatro giapponese, Genndy confeziona uno show in cui le parole sono un accompagnamento a tutto il resto, lasciando che sia la musica ad accompagnare principalmente l’azione. Samurai Jack, e vi sfidiamo a dire il contrario, è quasi del tutto privo di dialoghi. È stimato che nell’interezza dello show (quindi in tutte le sue stagioni) ci siano meno di 10 minuti di dialoghi in totale. 10 minuti, 4 stagioni. Tutto ha una sua logica: nella ricerca di uno stile sintetico e perfetto, Tartakovsky ha l’intuizione di ispirarsi a chi ha teorizzato la coniugazione perfetta tra movimento e parole: Kimitake Hiraoka. Poeta, drammaturgo, filosofo noto ai più come Yukio Mishima.
Rifacendosi al movimento della “Filosofia dell’Azione”, e in particolar modo allo straordinario testo dell’Hagakure, Mishima dà la sua personalissima visione della figura del samurai nel suo “La via del samurai”. Una visione chiara e moderna della filosofia del samurai: una figura che vive senza compromessi, che raggiunge il suo obiettivo trascendendo la paura della morte, e che persevera l’ideale di servizio fino all’estremo. Fino alla fine. Come saprete lo stesso Mishima perpetrò quest’idea fino al seppuku. Un atto drammatico e simbolico che voleva dimostrare la sua convinzione e la devozione per l’ideale. E così nel suo testo, dice:
“La prima cosa che il samurai dice, in una data circostanza, è importante all’estremo. Egli dimostrerà, con una singola osservazione, tutto il valore del samurai. In tempo di pace, è la parola a manifestare il valore. Anche in tempi di caos e distruzione, grande eroismo può esser rivelato da una singola parola. Si può dire che questa singola parola è un fiore del cuore.”
Samurai Jack è, a tutti gli effetti, una visione possibile (e plausibile) del samurai perfetto. La sua causa, la salvezza della Terra, viene perpetrata con invidiabile determinazione e, allo stesso modo del modello teorizzato nell’Hagakure, Jack è un samurai senza compromessi, che sacrifica sé stesso (più precisamente la vita nel proprio tempo) per sconfiggere il male. Inoltre, come ben esplicato da Mishima, Jack non ha bisogno che di poche parole, perché in quanto archetipo del samurai esprime sé stesso attraverso l’azione, che va oltre la parola e ne è sintesi. Meta-testualmente, è la stessa azione ad essere perfetta esplicazione della trama, e mettendo da parte ogni dialogo superfluo. Tartakovsky e il suo team confezionano episodi artisticamente impeccabili, in cui ogni inquadratura, ogni movimento, è al servizio della dinamica dei corpi. Non necessariamente al servizio dei combattimenti. Come intuirete, si tratta di tematiche che trascendono un prodotto confezionato per un pubblico giovane, e che impongono un certo tipo di ragionamento e di consapevolezza, eppure una delle bellezze e, per certi versi, la potenza di Samurai Jack è quella di poter essere goduto anche su di un piano più basilare e asciutto, fatto di semplice narrazione e azione. Uno show, insomma, a uso e consumo dei grandi come dei piccini.
Non solo: nel suo continuo sperimentare, e tracciate la basi di quello che è uno stile che lo show non perderà praticamente mai (è una sfida aperta ragazzi: trovateci un solo episodio di Samurai jack che non abbia un senso definito e che non sia apprezzabile), Genndy si diverte a ripescare le “gabbie” proprie delle tavole del fumetto americano, le inquadrature strette dal cinema western, le attese incessanti delle pellicole nipponiche, le battute nonsense che hanno fatto la sua fortuna con The Dexter’s Lab. Samurai Jack diviene ben presto un punto di riferimento per l’animazione, restando purtroppo confinato in una nicchia che, tuttavia, conta un nugolo di appassionati di tutte le età.

La fortuna, al di là di ogni sottesa filosofia, è l’azione stessa, che si manifesta spesso con dei ritmi accesi e forsennati. Dinamica. Jack si muove con velocità e naturalezza, Aku invece, nella sua forma longilinea e spesso sinuosa si diverte nel mostrarsi spesso in forme diverse e complesse (come a dire che il male maschera sé stesso e ha molteplici forme). Tutto è in contrasto con uno stile spigoloso, massiccio. Lo stesso samurai è squadrato, simmetrico, dall’aspetto quasi monumentale. Eppure a quegli angoli mal smussati si accosta un’animazione velocissima, con un uso sempre pulito dei movimenti. Siamo lontanissimi dagli esperimenti slapstick effettuati con Dexter, Samurai Jack vuole essere un prodotto da cinema sullo schermo di casa. Dalla lezione imparata con Il Laboratorio di Dexter, Tartakovsky riprende però la larghezza del campo, un effetto quasi “cinemascope”, che dà all’immagine un respiro invidiabile. Sia nel bel mezzo dei duelli, che nella proposizione dei diversi aspetti del futuro distopico di Aku.
L’artista si diverte allora a costruire scenari immensi e spettacolari, tra Mad Max e Blade Runner, passando da innevati boschi del mito celtico a deserti rossi richiamanti Tatooine. L’impatto visivo è semplicemente spettacolare. Genndy è dotato di un genio visionario, tale da riuscire a dare a ogni episodio una sua direzione precisa e fantasiosa. Jack si trova così a vivere decine e decine di avventure diverse, in cui cambia abito, combatte ninja, robot e creature mostruose, pur restando fedele alla sua filosofia, alla sua “tradizione”. Lo show si rifà esplicitamente all’uso del serial televisivo in cui una narrazione orizzontale (in questo caso la ricerca e la sconfitta di Aku) si accosta ad una verticale, ossia ciò che comincia, si svolge e finisce nell’arco del singolo episodio. E Genndy Tartakovsky si mostra in questo un autentico maestro, capace di lavorare per contrasti di una prepotenza quasi spiazzante. Nella sua costante ricerca estetica, il nostro riesce a confezionare episodi di una pomposa bellezza visiva, in contrasto con altri in cui il disegno diventa così asciutto da risultare, per certi versi, ermetico. Samurai Jack riesce, ben oltre il bisogno delle parole, a raccontare sé stesso e a spiegare l’azione con invidiabile perizia, tanto che in alcuni rari ma encomiabili momenti il Samurai di Cartoon Network, come detto, riesce a privarsi di tutto: parole, sfondi, superfici, dettagli e persino colori.

Il sunto è che Samurai Jack è una pietra miliare dell’animazione. Un progetto irripetibile la cui prematura conclusione ha marcato una dolorosa assenza nel panorama animato. Ora che Adult Swim, la cui nascita si deve proprio a prodotti come Samurai Jack, ha finalmente deciso di rimettere mano al brand con una quinta stagione, forse Jack troverà finalmente la pace ritornando nel suo tempo. Al di là di questo, se non ne avete avuto occasione, se ne eravate all’oscuro o semplicemente se non vi siete mai sentiti ispirati da Samurai Jack, allora la speranza è che con questo articolo, e soprattutto PRIMA di guardare la quinta stagione, anche solo per curiosità o per moda, vi andiate a ripescare le origini del Samurai di Tartakovsky godendovi le precedenti quattro stagioni. Non c’è un vero e proprio legame narrativo che vi obblighi a farlo, ma c’è un dovere morale verso quello che è lo stato dell’arte di un certo modo di fare animazione, senza il quale ogni visione della quinta stagione, permetteteci di dirlo, perde ogni senso e ragione.








