Come si coniugano la memetica imperante delle nuove generazioni al Festival più nazionalpopolare che ci sia nel nostro Bel Paese?

ossiamo dire che la rinascita sanremese sia frutto di una sincretica e fortunata unione di social e talent, di meme e di forme di protagonismo del pubblico – non più nella forma del tentato lancio nel vuoto dalla balaustra di Pino Pagano, ma come commentatore in diretta sui social e fantallenatore di squadre di cantanti?
Abbiamo chiesto un’opinione informata sui fatti a Vittorio Polieri e Adriano Pugno, autori di Perché Sanremo è Sanremo, Guida sentimentale al Festival e al suo pubblico, un saggio che affronta la sociologia del Festival con sguardo millennials.
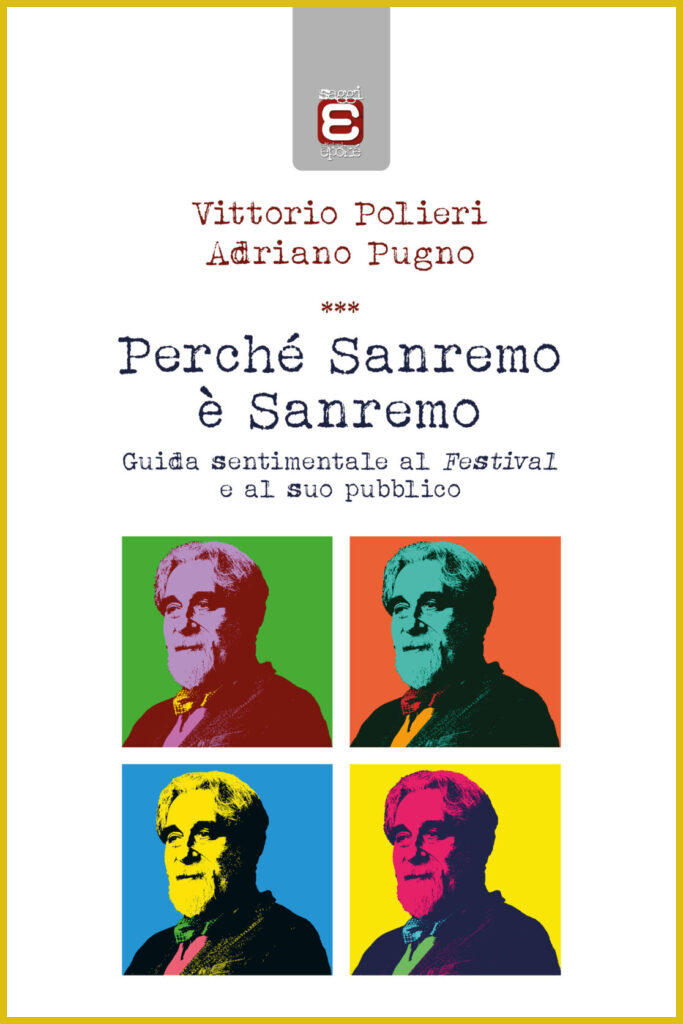
Fiori, neon, Robert De Niro, paillettes, FFP2.
Sono solo alcune delle uscite a bilancio della Rai nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo, e non una sola menzione a un social media manager. Beninteso, dalle origini di Facebook al boom del Metaverso la manifestazione ha sempre presidiato i social network, e da qualche anno l’ascesa di RaiPlay ha ulteriormente avvicinato il pubblico alla fruizione di contenuti digitali in second screen.
Ma il successo della kermesse, diciamolo pure, è tutto merito nostro. Ogni tweet, ogni reel, ogni post su Facebook (se avete più di cinquant’anni o siete dei nostalgici) ha ingigantito la bolla del consenso, l’ha resa impenetrabile. Comodamente seduti sul divano, temprati dalle sere d’inverno passate a fare il tifo per i Coma_Cose, abbiamo brandito il telecomando e lo smartphone, e li abbiamo confusi. La pizza fredda in tavola, la coca a temperatura ambiente, mentre eravamo intenti a scavare nel momento televisivo con amici e parenti, trasformando le chat di WhatsApp nel salotto glitterato di un talk-show.
La 72ª edizione del Festival della canzone italiana ha certificato due tendenze: la definitiva consacrazione del FantaSanremo come “grimaldello” della liturgia e la scelta del meme come principale codice di comunicazione – più veloce e intelligibile di una qualsiasi opinione di Luca Dondoni. Il meme occupa capitoli interi nei manuali di semiotica, ma la sua fortuna si deve all’utilizzo empirico, alla prassi, alla reiterazione di un “calco” che può essere correlato a molteplici situazioni, spesso in chiave nonsense.
Per farsi un’idea, basta scorrere il feed di Trash Italiano o dei The Jackal su Instagram, che nella settimana del Festival diventano la Treccani della cultura popolare: spopolano Mahmood e Blanco come il diavolo e l’acquasanta, Giusy Ferreri col suo megafono, Orietta Berti personaggio giocabile di Cyberpunk 2077.
I meme sono il corrispettivo goliardico della pasta col tonno, intuitivi e facili da confezionare; sono divertenti e immediati, diversamente dagli articoli dei cronisti che devono scrivere in calce il tempo di lettura – non c’è un solo istante da perdere tra il monologo di Lorena Cesarini e il collegamento con la Costa Toscana, lo sappiamo bene. E, soprattutto, i meme sono trasversali, non fanno distinzioni di ceto o grado d’istruzione, una variabile che consente loro di propagarsi in modo ancor più rapido e capillare, fino a diventare virali.
Segmenti iconici come il famigerato «Che succede?» del Bugogate sembrano nascere come ready-made, opere a portar via da completare con un breve testo in font Impact; ma gli approcci alla memistica, compresa quella sanremese, sono tanti e stratificati, alcuni addirittura autoriali, o rivolti a una specifica comunità di utenti.
Forse distinguere tra i contenuti brandizzati delle pagine a tema e quelli ricondivisi dalle persone comuni (il gentile pubblico a casa che una volta partecipava al concorso Telefortuna) è un esercizio ozioso – il meme vive sulla massa, sull’accumulo dell’identico e del fine a se stesso; ma tante realtà sperimentano ogni giorno nuove forme creative (su Instagram, @tuttelemelediannie unisce l’illustrazione all’istantaneità del trending topic), a conferma di un humus instabile e in continua trasformazione.
Visualizza questo post su Instagram
In questo senso, il Festival di Sanremo 2022 è un’impareggiabile fucina di contenuti (meme, GIF, immagini, brevi clip) che per cinque giorni impregnano il nostro tempo, lo scandiscono: finanche i cinguettii dei politici sembrano cadere in un inevitabile letargo settimanale. Quel che resta lontano dalle telecamere, semplicemente, non esiste.
Lo scarto rispetto ai Festival del passato è il passaggio da una dimensione centralizzata a una kermesse interattiva, dove ogni spettatore è insieme fruitore e content creator. Sono lontani i tempi del baudismo, dove ogni proposta artistica era appannaggio dell’uomo solo al comando: l’avvento dei social network, dei talent show, di nuovi spazi autoriali non definibili che nascono e germogliano sul web hanno portato Sanremo ad allontanarsi dal pubblico tradizionale, anziano e conservatore, per avvicinarsi ai millennials e alle loro consuetudini, all’idea di mondo che rappresentano. Non più evento, o non solo, ma rito condiviso.

Tra meme e coronavirus, la viralità è il segno del nostro tempo: i contenuti più condivisi escono dalla bolla sanremese per diventare patrimonio collettivo, luogo comune, espressione proverbiale. Capita di litigare e di rispondere «Le brutte intenzioni, la maleducazione».
E anche i sentimenti si piegano all’algoritmo, a caccia del Premio della Critica:
«E lasciati andare
che il cuore ti cade giù
e l’amore riappare,
va in tendenza e risale,
diventa virale».
P.S.
Il Festival, quest’anno, un social media manager ce l’ha. Ed è anche bravo. (E se non sono passi avanti questi…)
Articolo a cura di Vittorio Polieri e Adriano Pugno








