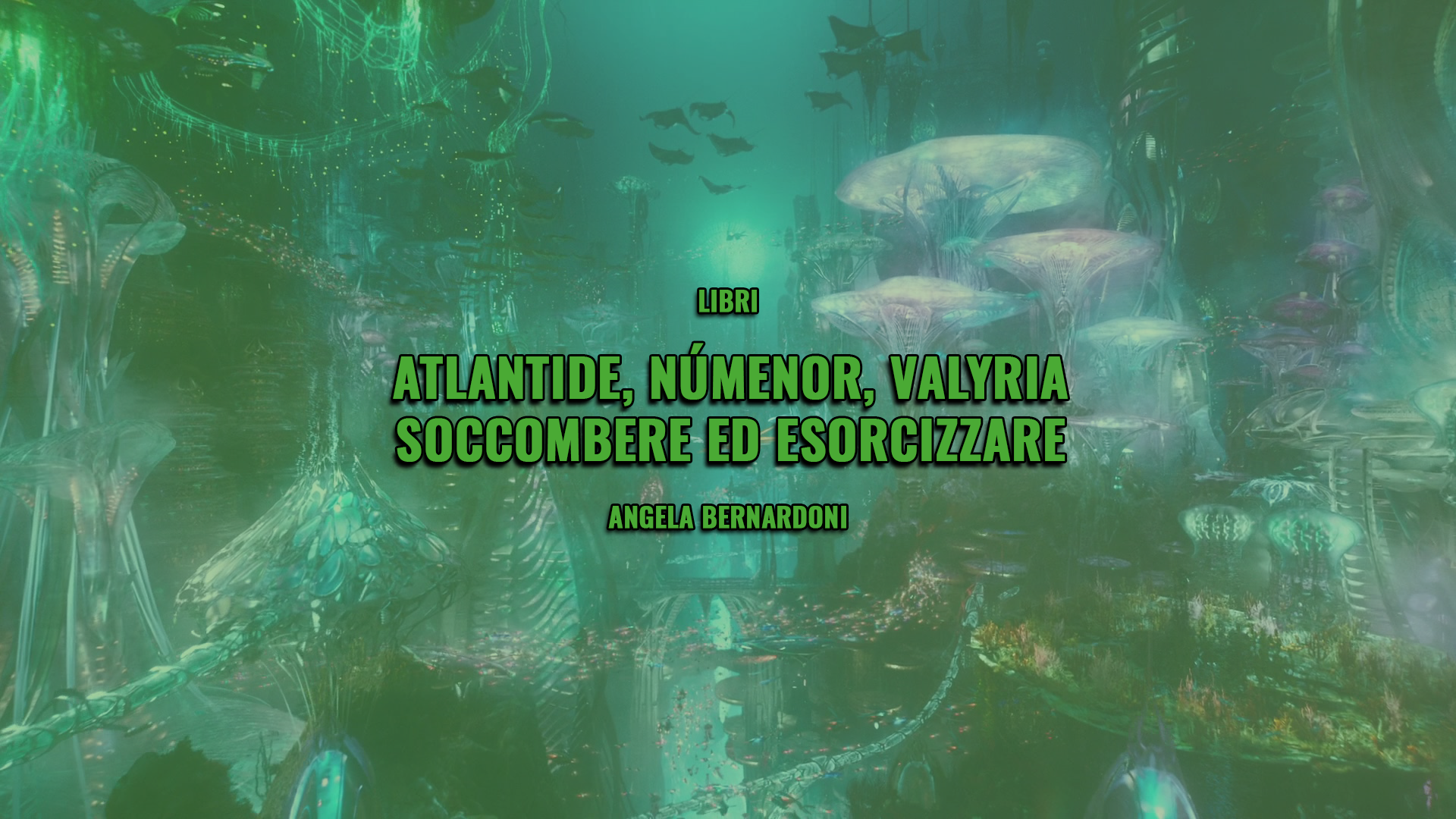Dal mito platonico alle rielaborazioni di Tolkien e Martin, Atlantide non smette mai di mettere in guardia le sue figlie e i suoi figli

i sono storie che ci trasciniamo dietro da così tanto tempo, che sembrano risalire alla notte dei tempi; archetipi ancorati nella parte più antica del nostro cervello, incastrati lì, nel romboencefalo, come se fossero essenziali funzioni di base alla nostra sopravvivenza (e forse lo sono). Tra queste storie che ci portiamo dietro dagli albori della società, spicca per longevità e varietà di interpretazioni il mito di Atlantide – archetipo così onnipresente da essere entrato a far parte della mitologia di due delle più conosciute saghe del fantastico moderno e contemporaneo.
Per scrivere questo articolo mi sono avvalsa di un ottimo compagno di viaggio: il saggio Benvenuti ad Atlantide, Passato e futuro di una città senza luogo di Marco Ciardi, appena pubblicato da Carocci editore. L’autore, professore ordinario di Storia della scienza all’Università degli Studi di Firenze, ripercorre la storia delle origini del mito, seguendone le mille diramazioni che attraverso letteratura, cinema, e fumetti, hanno tramandato la lezione atlantidea fino a noi. Con un approccio che coniuga ricordi dell’infanzia dell’autore e una conoscenza pressoché enciclopedica dell’argomento, Ciardi espone a chi legge la pluralità delle teorie legate all’esistenza – e alla scomparsa – di Atlantide da Platone a Namor.
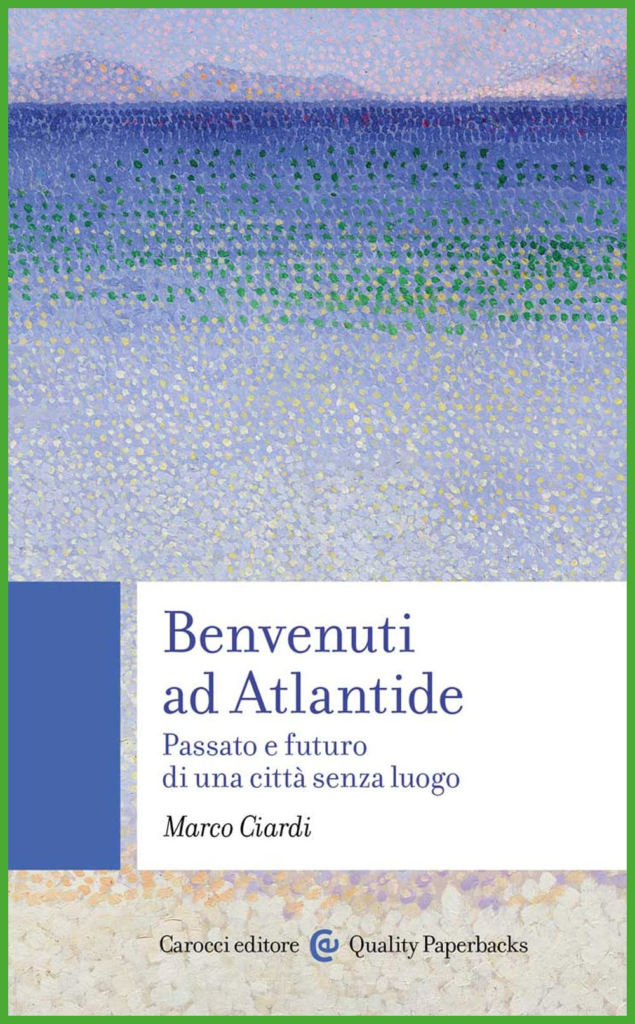
La prima menzione scritta della città di Atlantide, infatti, si trova proprio nei dialoghi platonici Timeo e Crizia, risalenti al IV secolo a.C., ma sembra che lo stesso filosofo sia stato influenzato, nella creazione della sua parabola ammonitrice, dalle storie provenienti dall’Egitto. Nei dialoghi, soprattutto nel secondo, si approfondisce la storia della creazione dell’isola – dono del Dio Poseidone ai dieci figli avuti con la mortale Clito – e la sua geopolitica; è invece nel Timeo che se ne dà l’esatta collocazione spazio-temporale: la caduta di Atlantide, isola più grande della Libia e dell’Asia messe insieme situata davanti alle Colonne d’Ercole, ha avuto luogo novemila anni prima del momento in cui il politico Crizia ne narra la triste fine ai filosofi Socrate e Timeo di Locri.
Dai tempi di Platone a oggi, con alterni focolai di interesse e diverse chiavi di lettura (ancora negli anni ‘70 del secolo scorso il giornalista esperto di pseudoscienze Peter Kolosimo, nel suo Non è terrestre, avanzava tesi sulla reale esistenza di un’isola sprofondata a largo dell’Oceano Atlantico), l’isola non ha mancato di affascinare i più insospettabili degli scrittori: Conan il barbaro, personaggio fondativo dell’heroic fantasy creato nel 1932 da Robert Ervin Howard, è infatti un figlio di Atlantide. Il barbaro Conan – portato al cinema nel 1982 e nel 2011 con il volto e i muscoli di Arnold Schwarzenegger e Jason Momoa – è conosciuto anche come Conan il Cimmero dal nome della sua patria, quella Cimmeria che secondo Howard è stata fondata prima dell’inizio della storia per come la conosciamo noi, dai discendenti dei popoli di Atlantide, fuggiti prima del definitivo inabissamento dell’isola. Una volta giunti sulla terra ferma, orfani della loro patria e della tecnologia avanzata sviluppata dalla loro civiltà, gli atlantidei regredirono alla barbarie, dimenticandosi le loro origini, di cui troviamo però traccia – nella sterminata bibliografia di Howard – nella saga di Kull di Valusia, ambientata prima della catastrofe.
Ancora prima di Howard, Atlantide compare tra le pagine delle Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne (1870) come città morta nelle profondità marine, esplorata dal professor Pierre Aronnax e dal Capitano del Nautilus, Nemo, in una delle loro passeggiate acquatiche. Sempre attento all’attendibilità scientifica, Verne ripercorre la storia di Atlantide, ne indentifica la causa di disgrazia con una serie di esplosioni vulcaniche, ma non fa menzione di sopravvissuti, o di tecnologie avanzate (a scombinare le carte, creando un ponte concreto tra Atlantide e il Capitano Nemo ci penserà, un secolo dopo, Hideaki Anno – su soggetto di Hayao Miyazaki – con Fushigi no umi no Nadia, conosciuto in Italia come Nadia, Il mistero della pietra azzurra). Neanche Sir Arthur Conan Doyle ha resistito al fascino del continente scomparso: in L’abisso di Atlantide, del 1929, l’autore immagina un’Atlantide ancora popolata, tecnologicamente avanzata, ma tenuta in scacco dalle forze malvagie che l’hanno portata in primo luogo alla rovina. In questo caso la plausibilità di Verne lascia il passo alle teorie spiritiste di moda nella Londra degli anni ‘20 del 1900, mettendo in scena uno scontro epico tra il bene e il male.
Uno dei punti di forza della storia di Atlantide è la sua declinabilità: che sia l’atlantide dark weird di Clark Ashton Smith, o quella crystalpunk del classico Disney Atlantis, l’isola si adatta alla storia che le viene narrata intorno, come nel caso del primo romanzo italiano di fantascienza pubblicato nella storica collana Urania, L’Atlantide svelata (Romanzi di Urania n.31) di Emilio Walesko (probabilmente uno pseudonimo), che non nasconde il suo debito tematico nei confronti di Doyle. Proprio per questa sua capacità proteiforme, Atlantide è stata usata come modello per due civiltà scomparse che hanno un ruolo fondamentale nel mondo tolkieniano di Arda e nell’universo narrativo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin.

Come si legge in una lettera scritta da Tolkien al poeta W.H. Auden e riportata da Ciardi nel secondo capitolo del suo Benvenuti ad Atlantide, la decisione di inserire il mito dell’isola sprofondata nella sua produzione ha una spinta peculiare: “io ho quello che molti chiamerebbero un complesso di Atlantide. Probabilmente ereditato, benché i miei genitori siano morti troppo presto perché io venissi a sapere certe cose di loro, e troppo presto per trasmettermi con le parole queste cose. […] Sto parlando del terribile sogno ricorrente (che comincia con il ricordo stesso) della grande ondata, torreggiante e che avanza ineluttabilmente sopra gli alberi e i campi verdi”. Il modo in cui Tolkien esorcizza la grande onda è la scrittura; la sua Númenor – situata nel Grande Mare Belegaer, tra la Terra di Mezzo e il continente di Aman – è una culla della civiltà umana, un luogo in cui la cultura e la società degli Edain si nutriva di proficui scambi con quella degli Elfi della vicina Valinor. Solo l’invidia avrebbe potuto incrinare questo reciproco rapporto: gli abitanti di Númenor – già ben più longevi degli altri Uomini – iniziarono a desiderare l’immortalità, a rifiutare le lingue elfiche, a perseguitare gli amici degli elfi (e questo è il punto della storia di Númenor che abbiamo visto nella prima stagione de Gli anelli del potere).
Númenor, che nella lingua degli Elfi dell’Ovest porta il nome Atalantë (da talat, tema che indica lo scivolare, il cadere giù, in quenya), trova la sua rovina nella cupidigia e nella guerra. L’ultimo re, Ar-Pharazôn, scatenò le ire dei Valar invadendo Valinor e causando la caduta di Númenor e la rimozione del continente di Aman da Arda per mano di Eru Ilúvatar. La Terra d’Occidente – questo il significato nella nostra lingua di Númenor – fu cancellata dalle mappe a causa del suo desiderio di vita eterna, di avere di più, di non riuscire ad accontentarsi di essere già i più fortunati tra gli uomini. Volendoci rifare alla tradizione biblica cara al Professore, Númenor è la cacciata dal paradiso terrestre, Sodoma e Gomorra, Babilonia e il vitello d’oro di Aronne (oltre all’immancabile e già citato diluvio universale).
E se John Ronald Reuel Tolkien si rifà alle fonti classiche per la sua cosmogonia, George Raymond Richard Martin non è da meno: così come la stirpe di Elendil raggiunge le rive della Terra di Mezzo – fondando i regni di Arnor e Gondor e aprendo la Terza Era -, la casa dei Targaryen conquista il trono di Westeros dopo il Disastro di Valyria, resettando il calendario dei Sette regni, e dividendo la storia in Prima della conquista e Dopo la conquista.
Nell’introduzione di Fuoco e Sangue, il volume che Martin ha dedicato alla stirpe delle signore e dei signori dei draghi, si scopre che, proprio come da tradizione atlantidea, “al suo apice Valyria era stata la più grande città del mondo conosciuto, il centro della civiltà” e che se i Targaryen, unici tra le casate, sono sopravvissuti alla fine della loro civiltà è stato grazie a Daenys la Sognatrice – figlia di lord Aenar e antenata di Aegon il Conquistatore – che previde la fine di Valyria dodici anni prima dell’effettiva distruzione della stessa, spingendo la sua famiglia a stabilirsi a occidente, a Roccia del Drago.

È in un capitolo de La danza dei draghi, quinto volume delle Cronache, che viene narrata la fine di Valyria, sebbene non ne venga presentata una causa: l’aria si riempì di cenere, fumo e fiamme; terremoti distrussero palazzi, templi e città; i laghi ribollirono; le Quattordici Fiamme esplosero in nubi rossastre e dalla loro cima piovvero pezzi di vetro di drago. Del Disastro restano resoconti in forma di canzone e rappresentazioni artistiche, ma andarono perdute per sempre le saggezze valyriane: le tecniche di lavorazione dell’acciaio di Valyria, le arti magiche, una certa tendenza alla preveggenza che sopravvisse nei Targaryen e nei Targaryen soltanto.
Valyria, così come Númenor e Atlantide, sembra raccontarci una paura atavica ricorrente: la scomparsa della civiltà, il soccombere alla natura, la consapevolezza che tutta la nostra tecnologia – che persino i draghi – non ci salveranno davanti alle conseguenze delle nostre azioni, delle nostre scelte sbagliate, all’invasione delle terre degli elfi. Come il Complesso di Atlantide descritto da Tolkien sembra sottolineare, il terrore della cancellazione della società, del trovarci sommersi dai nostri stessi errori, trascinati in mare aperto, trasformati in leggenda per le pseudoscienze vive in noi, che potremmo o meno essere figlie e figli di Atlantide, ma che di sicuro – a 2500 anni di distanza da Platone – ancora usiamo le storie per esorcizzare la paura di non lasciare traccia su questo mondo, se non sotto forma di argomento di dibattito per l’archeologia del futuro, se non sotto forma di esuli dannate e dannati per il resto della loro vita.