Cosa vi viene in mente, se vi dico la parola zombie?
Carne marcescente, bipedi a deambulazione più o meno lenta, cervelli mangiati (anche se poi, la maggior parte degli zombie si accontenta di un arto qualsiasi in cui affondare i denti), crani fracassati e mani che spuntano dal terreno, pronte ad artigliare le caviglie dei malcapitati vivi.
L’immaginario collettivo ha contribuito a far sì che l’estetica zombie sedimentasse nel cervello dell’umanità e i non-morti hanno rapidamente abbandonato la loro terra di origine, Haiti, per invadere il mondo (con una preferenza, condivisa con gli alieni, per il territorio statunitense). Ma gli zombie, da George A. Romero in poi, non sono mai stati solo morti viventi, e sotto i loro abiti stracciati e la carne in putrefazione si nasconde una teoria infinita di metafore.
I morti viventi della notte di Romero sono un mezzo, neanche tanto velato, per parlare dei problemi razziali che infestavano gli USA negli anni Sessanta; problemi che non sono certo scomparsi con il tempo e di cui si parla ancora oggi, sempre usando l’horror come veicolo, nei film Get Out e Us di Jordan Peele.

Razzismo e zombie, un’accoppiata vincente
Fin dalle loro prime apparizioni sul grande schermo, quando ancora erano haitiani e sotto il controllo di uno stregone voodoo, gli zombie sono stati simbolo del diverso di cui avere paura: il primo zombie movie – White Zombie del 1932 – vede una coppia WASP cercare di sopravvivere alle barbarie primitive di Haiti, luogo senza dio e senza regole, in cui gli stregoni sono realtà e i morti tornano in vita per lavorare nelle raffinerie di zucchero, da bravi schiavi.
Nel corso degli anni, gli zombie hanno incarnato gran parte delle paure del mondo occidentale: negli anni Quaranta la magia dei bokor lascia il posto alle radiazioni nucleari del mondo post-atomica, come nel film Creature With the Atom Brain (1955). Da questo momento, la spiegazione pseudoscientifica della mutazione sostituisce la magia haitiana e gli zombie, da creazione volontaria di un folle, diventeranno sempre più spesso un incidente di percorso sulla strada della sperimentazione di un nuovo farmaco, o pesticida. Una volta finita la guerra fredda, il tropo dello zombie come perfetto soldato indottrinato che vediamo in fumetti come Corpses: Coast to Coast (1954) passa di moda, favorendo il diffondersi dell’apocalisse zombie come errore umano e non come malvagio piano di assoggettamento della popolazione mondiale.
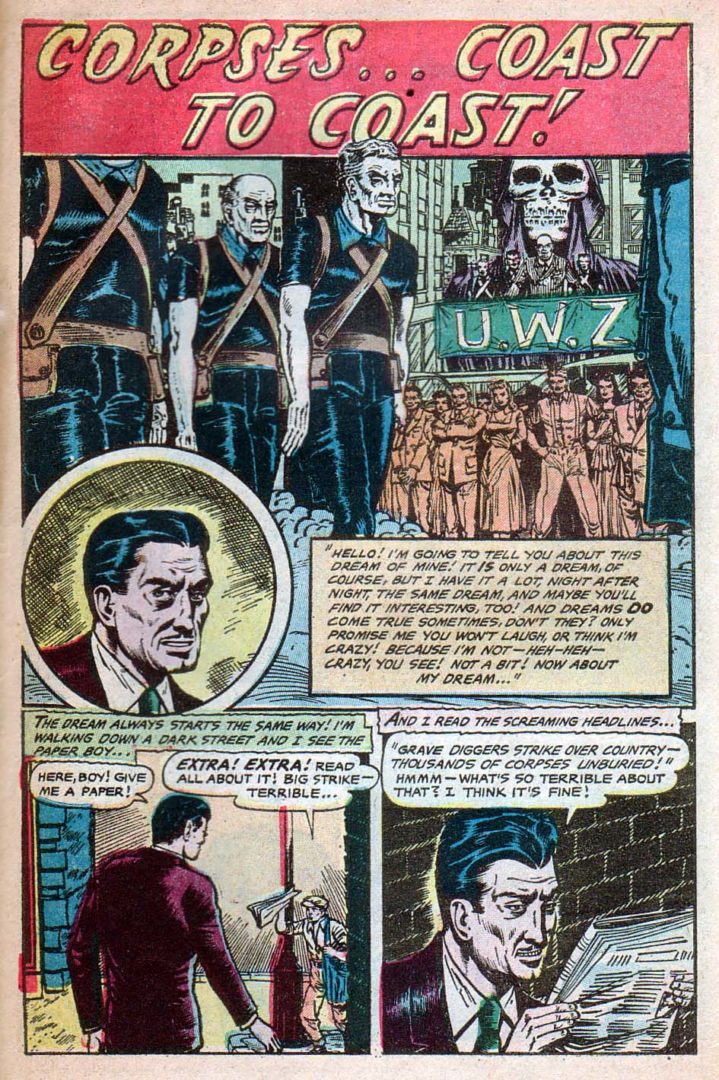
Con il passare del tempo gli zombie sono diventati sempre più pericolosi, veloci, famelici proprio perché, eliminando il controllo dello stregone a cui erano legati, cade l’ultimo baluardo tra la loro potenza distruttiva e la fine del mondo. Le apocalissi, su scala sempre più vasta – come Resident Evil insegna – costringono i sopravvissuti a non abbassare mai la guardia contro un nemico più stupido di loro, ma che può contare sulla forza della superiorità numerica e della totale dedizione a un unico obiettivo: uccidere.
Zombie come metafora: la sottile arte di dissimulare
Parlare di zombie come metafora non significa cercare di elevare il genere negando le sue caratteristiche (il classico non è solo fantascienza amato dai giornalisti culturali alle prese con romanzi complessi che esulano dal realismo), ma riconoscere la profondità di opere che riescono nell’intento di intrattenere lo spettatore o il lettore senza cadere nel vuoto pneumatico.
Del resto è molto difficile creare un’opera che non abbia nessun messaggio, nessun secondo livello di lettura, e questo è più vero che mai per la narrativa di genere, che da sempre parla del presente mascherandolo da futuro (o da presente alternativo, o da passato fantastico). Parlare di qualcosa per parlare di altro resta, nel mondo a comparti dell’editoria italiana, un buon modo per infiltrare gli zombie in case editrici come Einaudi, che ha portato in italia l’apocalisse di Colson Whitehead Zona uno, mentre Codice Edizioni, meno assoggettata allo snobismo letterario, ha avuto il merito di aver appena portato in Italia il romanzo di esordio dell’autrice sinoamericana Ling Ma, Febbre.
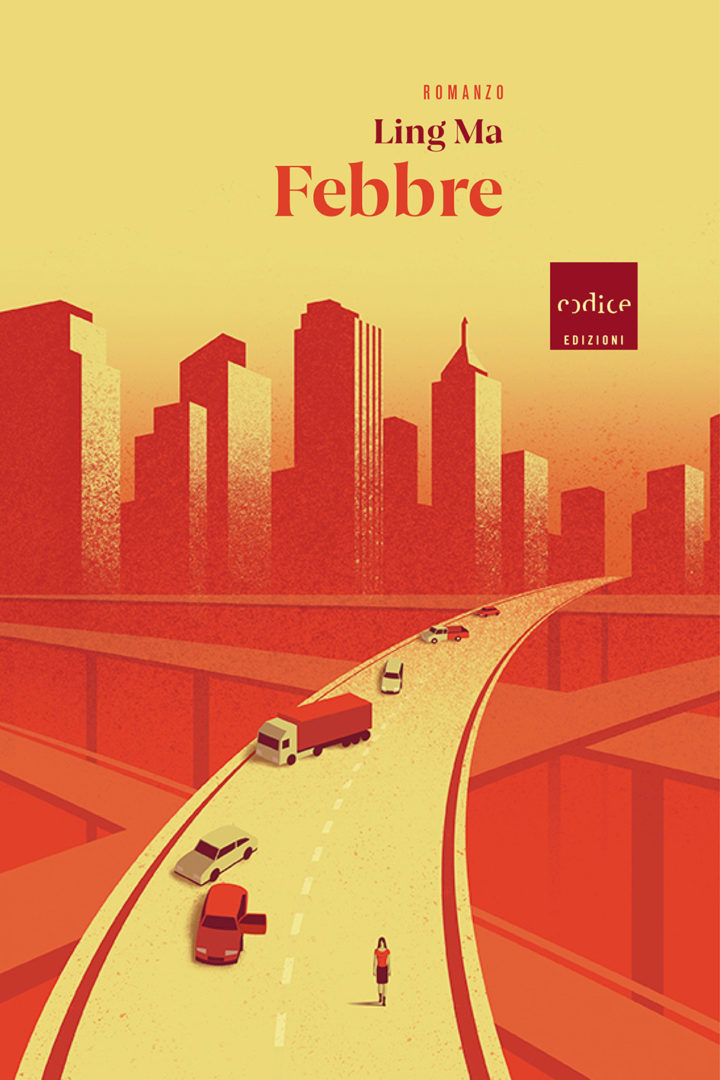
Siamo a New York, l’anno è il 2011. Un’epidemia dalla Cina, la febbre di Shen, trasforma i malati in individui senza volontà, corpi in cui solo la memoria delle azioni compiute in vita sopravvive. Come macchine di una catena di montaggio, i non morti apparecchiano e sparecchiano incessantemente la tavola, spiegano e ripiegano a ciclo continuo le maglie nei negozi in cui lavoravano, camminano intorno ai luoghi della loro infanzia. Quelli di Ling Ma non sono zombie aggressivi, sono a malapena zombie, ma incarnano le paure della nostra generazione, e lo fanno rimanendo immobili nel luogo in cui sono, vittime della ripetitività e della monotonia. Proprio come ingranaggi di una fabbrica globale, i malati di febbre sono l’estrema rappresentazione di quello che ogni essere umano è: un morto ancora vivo.
L’economia è morta e la nostra voglia di vivere anche
Il punto di forza della scrittura di Ling Ma non si trova certo nella trama innovativa che, al contrario, sfrutta tutti i trope del genere – dal centro commerciale come luogo sicuro al leader religioso pazzo – per mettere a proprio agio il lettore e permettergli di concentrarsi sui temi che realmente le stanno a cuore, ma proprio nell’acutezza con cui l’autrice espone il suo piccolo trattato sull’economia morente dell’Occidente nella cornice della morte dell’umanità.
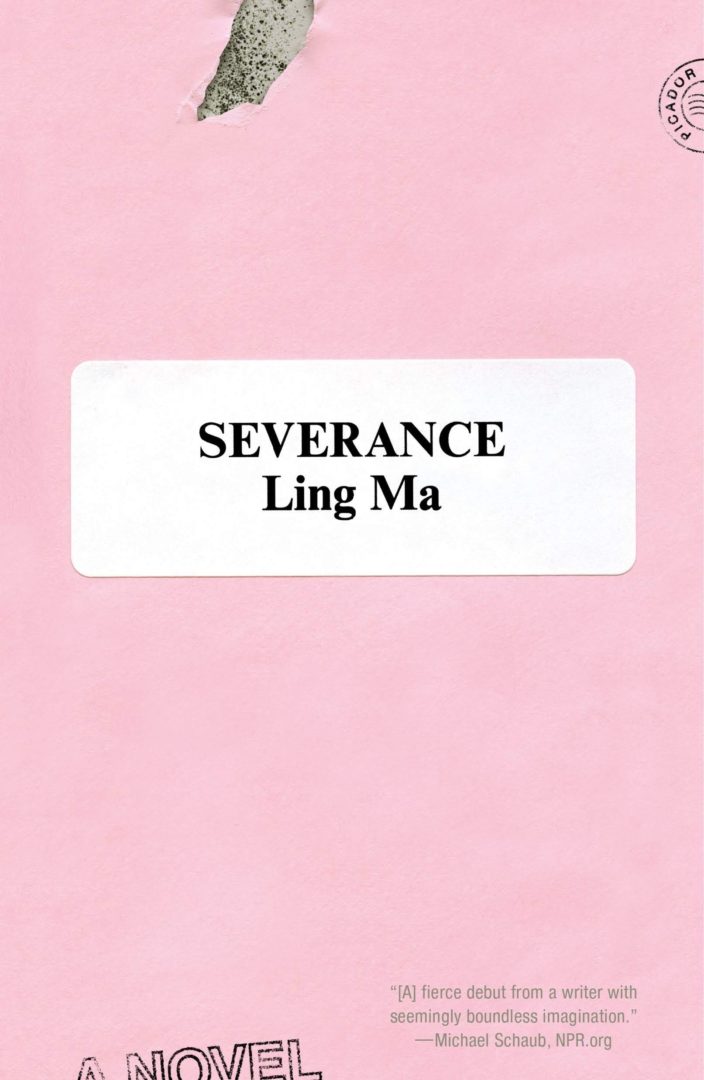
Quello che a prima vista potrebbe sembrare un romanzo della migrazione, incentrato sul senso di famiglia e di origine, rivela invece la sua potenza nell’analisi della situazione lavorativa dei millennial: nel rapporto tra la protagonista, Candace, e il suo partner, Jonathan, possiamo leggere il forte contrasto tra chi lavora per vivere e chi, viceversa, vive per lavorare. Sullo sfondo di una New York sempre meno frenetica e sempre più senza scopo, i flashback abbandonano gradualmente la narrazione dell’infanzia e della famiglia per concentrarsi sull’impalpabile carriera di Candace, su quel senso di dovere che la spinge a non abbandonare il suo posto finché niente sembrerà avere più senso.
Non è un caso, infatti, che la copertina dell’edizione originale di Febbre, Severance – termine che indica la liquidazione pagata a fine rapporto di lavoro – sia una piatta campitura di quel rosa rinominato millennial pink: Ling Ma fa parte di quella generazione nascente di scrittrici, come Sally Rooney e Carmen Maria Machado, in grado di esprimere le insofferenze e gli equilibrismi di una generazione senza alcuna certezza se non quella, radicata nel profondo, di sfuggire l’insensata monotonia di una vita già decisa, per non diventare zombie in una società di sopravvissuti.








